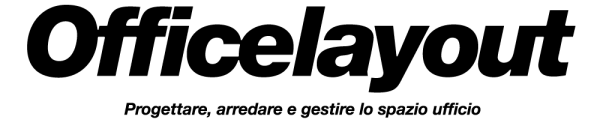Faccia a faccia con Gaetano Settimo
Quando si parla di qualità dell’aria nella maggior parte dei casi il pensiero va agli spazi esterni e all’inquinamento atmosferico outdoor, sebbene l’aria che respiriamo quotidianamente è quasi esclusivamente quella presente negli spazi chiusi indoor, dove si stima che si trascorriamo oltre il 90% del nostro tempo, che risulta spesso più inquinata di quella esterna. […]

Quando si parla di qualità dell’aria nella maggior parte dei casi il pensiero va agli spazi esterni e all’inquinamento atmosferico outdoor, sebbene l’aria che respiriamo quotidianamente è quasi esclusivamente quella presente negli spazi chiusi indoor, dove si stima che si trascorriamo oltre il 90% del nostro tempo, che risulta spesso più inquinata di quella esterna.
Anche negli spazi di lavoro moderni, che mettono al centro il tema del benessere delle persone, il parametro della qualità dell’aria è spesso trascurato, nonostante abbia un’incidenza diretta sulla salute delle persone, sulla produttività e la qualità dei servizi e sul successo aziendale a lungo termine.
Un gap culturale che viene in parte colmato dalla nuova UNI 11976:2025 “Ergonomia dell’ambiente fisico – Strumenti per la valutazione della qualità dell’aria interna” che introduce criteri oggettivi e operativi per monitorare e migliorare l’aria indoor negli edifici civili: da residenziale al terziario, sino agli edifici per l’istruzione.
Nello specifico la norma definisce le modalità per rendere ripetibile e riproducibile il processo di registrazione delle informazioni che portano alla valutazione della qualità dell’aria indoor. Obiettivo primario della norma è la tutela della salute degli occupanti degli edifici.
Con il professore Gaetano Settimo, Coordinatore del Gruppo di Studio Nazionale (GdS) Inquinamento Indoor – Dipartimento di Ambiente e Salute | Istituto Superiore di Sanità, abbiamo approfondito il percorso di studio e analisi che ha portato alla definizione dei contenuti della norma.
Con la norma UNI 11976:2025 la qualità dell’aria torna a essere un tema centrale nella prevenzione e nella tutela della salute delle persone. Quali sono stati, a monte, i passaggi che hanno portato a far evolvere l’approccio a questo importante tema?
Sicuramente in tutti questi anni si è lavorato seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Importante è stato il lavoro svolto dai ricercatori italiani nel mettere, tra i principi fondamentali delle diverse attività, la salvaguardia della salute in modo significativo attraverso la prevenzione primaria. L’obiettivo è anticipare ed evitare che la persona entri in contatto con le sostanze inquinanti presenti negli ambienti indoor evitando le problematiche sanitarie connesse. E solamente con questa grandissima attenzione a prevenire e ridurre l’esposizione personale agli inquinanti presenti nei diversi spazi indoor, intervenendo prima con azioni piuttosto che con reazioni, che siamo riusciti a dare slancio al tema.
Tante le barriere culturali da abbattere. Spesso infatti c’è la convinzione, come è stato nel periodo del covid, che con la semplice misurazione della CO2 o con la semplice presenza di un impianto di ventilazione meccanica, si possa giungere al totale miglioramento della qualità dell’aria. Non è così, il miglioramento della qualità della indoor non è mai un evento, è piuttosto un processo di costante e continuo miglioramento. Cioè va affrontato tenendo conto di quella che può essere la complessità di un qualsiasi ambiente indoor. Si dovranno tenere dunque in considerazione importanti elementi come la localizzazione, l’età dell’edificio, gli interventi di efficientamento energetico, la presenza e il tipo di finestrature, le tipologie di attività svolte, ecc. Sarà necessario fare incontri, sopralluoghi, parlare con gli operatori e catalogare le informazioni, cercando di fare sintesi per poi elaborare una possibile strategia orientata a superare le criticità emerse.
Quali aspetti sono stati determinanti nel percorso che ha portato alle indicazioni dell’OMS?
Come sostiene l’OMS, è all’interno degli ambienti chiusi che si costruisce lo stato di salute della popolazione, perché se analizziamo la nostra giornata, la stragrande maggioranza del tempo, e quindi dell’aria che noi respiriamo quotidianamente, è aria indoor. Pertanto, non si può continuare a utilizzare i dati delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria esterna per la valutazione dell’esposizione agli inquinanti, perché non sono dati significativi. È un po’ quello che viene definito “paradox of air pollution”, cioè siamo concentrati su ciò che avviene all’esterno quando la totalità dell’esposizione agli inquinanti atmosferici avviene all’interno.
Quindi si è lavorato sul tema delle evidenze scientifiche e sul ruolo che oggi riveste la qualità dell’aria indoor. Le attività di monitoraggio e raccolta dati, seppur grezzi, hanno dato una fotografia importante delle caratteristiche della qualità dell’aria presente negli spazi indoor: molti inquinanti di natura chimica e biologica già noti o nuovi all’interno di questi ambienti chiusi è significativa e, come detto, spesso superiore rispetto agli esterni. Se poi si associa nell’analisi il tempo di permanenza, si raggiungono livelli di inquinanti che determinano effetti sanitari. Per assurdo, si pensa sia meglio non aprire le finestre perché l’aria esterna è inquinata; invece, così facendo non si fa che aumentare i livelli di inquinanti indoor.
Sulla base di questa crescente consapevolezza. Quali sono gli obiettivi e gli ambiti applicativi della Norma?
Gli obiettivi della Norma sono aumentare la conoscenza degli inquinanti presenti negli ambienti indoor che sono complessi e in continua evoluzione. È necessario migliorare il nostro approccio di valutazione del rischio in tutta una serie di azioni.
Ad esempio, difficilmente i prodotti e i materiali che costituiscono gli ambienti dove viviamo e lavoriamo vengono scelti tenendo in considerazione le caratteristiche degli ambienti, le dimensioni, i volume, le altezze, le condizioni di utilizzo, di pulizia e di manutenzione degli stessi. Attenzioni che possono aiutare a ridurre le emissioni immediate, ad esempio l’odore di vernice o di mobile nuovo che la persona percepisce, e le emissioni di lungo periodo come avvenuto in passato con l’amianto, che con il tempo rilasciava fibre. Quindi quando si inseriscono nuovi materiali è necessario conoscere quali possono essere gli effetti sanitari sul medio lungo periodo.
Nell’immaginario collettivo all’odore di una pittura, di un mobile nuovo, di un detergente o di un deodorante per ambienti viene associata un’idea di igiene, di purificazione. E invece non è così. Il pulito non ha odore.
Oggi il grosso delle attività di ricerca scientifica si basa sulle reazioni che si generano dall’interazione delle diverse molecole di inquinanti rilasciate dalle numerose sorgenti a seguito delle condizioni di temperatura e umidità presente negli ambienti indoor. Reazioni che portano alla formazione di sostanze che sono spesso molto più pericolose dei prodotti iniziali.
L’obiettivo della Norma è quindi portare a una migliore comprensione delle emissioni dai materiali e dai processi svolti, dei fattori che possono influenzare le emissioni, come queste emissioni possono influenzare l’esposizione dei fruitori e come le esposizioni contribuiscono ai rischi per la salute. Questo lavoro è essenziale per supportare azioni, per progettare le attività di monitoraggio e per caratterizzare individuare le azioni di mitigazione del rischio per la salute.
Alcuni paesi come la Francia hanno introdotto l’etichetta “Air Intérieur” che indica il livello di emissioni di composti organici volatili (COV) di un prodotto in ambienti chiusi. Questa etichetta, tiene in considerazione tra i vari parametri anche al concetto di odore, cioè tutto quello che io porto dentro un edificio non deve avere odore. Proprio perché la presenza di un odore è un indicatore di una sorgente attiva.
Quali sono gli strumenti presi in considerazione dalla norma per il raggiungimento degli obiettivi?
Il primo step sono gli incontri in azienda con tutte quelle figure che, a partire dal management, dal responsabile della sicurezza al singolo lavoratore, permettono acquisire una serie di informazioni sulla qualità dell’aria indoor e se questa tematica è parte integrante dei valori e della filosofia dell’azienda, seguite da indicazioni sulle necessità e sui possibili margini di miglioramento. Uno strumento di secondo livello è il monitoraggio, con raccolta dati sul campo che possono confermare o cambiare la prima lettura o interpretazione delle informazioni acquisite.
Si parla di costante e continuo miglioramento, perché gli edifici nel corso del tempo variano il loro comportamento, variano le modalità di occupazione, varia spesso anche la modalità organizzativa. Basti pensare a come il lavoro ibrido abbia cambiato la fruizione degli spazi ufficio.
Quali categorie di inquinanti vengono considerate? E quali passi previsti per il raggiungimento degli obiettivi?
Gli inquinanti vengono classificati principalmente in funzione alla loro natura. Le principali categorie sono gli inquinanti chimici (composti organici volatili COV e polveri PM10 e PM2.5); gli inquinanti fisici (gas radon) e gli inquinanti biologici (virus, batteri, muffe e allergeni).
Il grosso dell’attenzione è rivolto agli inquinanti organici dalla formaldeide al benzene, dalle diossine ai PCB che fino agli anni ‘50 e ‘60 venivano utilizzati come isolanti per l’edilizia, dal PM10 PM2,5 agli odori, dal monossido di carbonio all’ozono, dai virus alle muffe e agli allergeni. Inoltre grande attenzione alle microplastiche, ai materiali nano ingegnerizzati, perché anche questi ultimi, a seconda del ciclo di vita e dell’usura, fanno sentire la loro presenza.
Sulla base di queste considerazioni la norma aiuta ad avere un quadro dell’entità dell’inquinamento dell’aria indoor e, in funzione di esso, si devono elaborare i piani di riduzione del rischio.
Quali le ricadute sulla pianificazione degli interventi?
L’esempio banale che le posso fare per dare forza a questo concetto è che quando in casa si rompe il tubo dell’acqua, la prima azione che si fa è quella di chiudere l’acqua. Di conseguenza, una volta che il monitoraggio ha permesso di individuare le sostanze che contribuiscono maggiormente all’inquinamento dell’aria indoor, la prima azione da compiere è quella di limitarli o eliminarli del tutto.
Un altro elemento che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi è aumentare la consapevolezza delle conseguenze dell’azione comportamentale e di formazione specifica. Manca infatti una formazione su come dobbiamo comportarci all’interno del nostro spazio lavorativo, in banca, alle poste, a scuola, o nella nostra abitazione. La scarsa attenzione nelle modalità di utilizzo degli spazi, nei dosaggi dei prodotti o anche nella semplice gestione di quella che può essere l’apertura delle finestre, o il funzionamento degli impianti di ventilazione meccanica o delle prese dell’aria, spesso chiusi perché danno fastidio.
L’altra azione voluta dalla norma è spingere il datore di lavoro, con tutte le figure che lo supportano, a elaborare fin da subito un piano sulla qualità dell’aria indoor che deve venir riconosciuta come un valore condiviso, parte della filosofia aziendale.
Quello che si è fatto fino adesso sul tema della qualità della indoor è stato come mettere il cerotto alla gamba rotta. Dobbiamo invece cercare di far comprendere che tutte le azioni messe in campo hanno un unico obiettivo: migliorare le condizioni di salubrità dei nostri edifici. E hanno come immediato riscontro una maggiore qualità dell’operato dei nostri lavoratori. È poi importante, quando si interviene, dare comunicazione delle azioni messe in campo, su base di evidenze scientifiche, per le proprie persone.
Come si riflettono gli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria sugli obiettivi di efficienza energetica degli edifici?
Il ruolo del dell’efficientamento energetico, per il legislatore europeo è ben chiaro: gli interventi di efficientamento energetico non hanno come obiettivo esclusivo la riduzione dei consumi, ma devono contribuire al superamento delle diseguaglianze abitative, affinché sia garantita una casa dignitosa e sicura per tutti. E la qualità dell’aria indoor è fondamentale per questo obiettivo. Quindi, per tornare alla sua domanda, i due temi sono complementari e non contrapposti soprattutto quando si utilizzano parametri di valutazione centrati sulla salute. Anche perché molti degli interventi di efficientamento che offrono vantaggi immediati in termine economici, di riduzione di alcuni costi in bolletta, possono rappresentare, se non correttamente progettati tenendo in considerazione la qualità dell’aria indoor, un problema per la salute con possibili costi a carico del servizio sanitario.
Che riflessi potrà avere la crescita di consapevolezza che spinge la norma sulla progettazione degli smart building e degli uffici?
Sicuramente porterà verso un profondo ripensamento del ruolo che svolge l’ambiente costruito nella salvaguardia della salute. Dobbiamo passare dal considerare gli edifici verdi e intelligenti, al concetto di edifici salubri non più concentrati esclusivamente sull’efficienza energetica quale elemento di salvaguardia costante e continua della salute. Questo è un passaggio fondamentale a cui tutti i professionisti, dai progettisti alla componente medica, dovranno porre maggiore attenzione.
Perché se devo costruire una scuola, un reparto ospedaliero, una banca o un centro commerciale devo seguire un approccio organico che tenere conto degli standard di riferimento, dei fruitori, per esempio dei ragazzini, del personale impegnato nelle attività scolastiche, sanitarie, alla parte amministrativa, ai clienti, ai pazienti, la qualità edificio, i layout degli spazi, l’efficienza energetica, l’occupazione, la formazione, gli impianti, la gestione e la manutenzione.
Questa norma non è altro che la summa dei rapporti elaborati dal Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
È importante agire in tutti quei luoghi dove si costruisce la salute a partire dai luoghi di lavoro, dalla scuola, dagli ospedali, dalle case, perché essendo costantemente fruiti dalla popolazione, è lì che si può trarne vantaggio.
Quali sono i benefici attesi dalla norma?
Lavorare su questa visione centrale della prevenzione primaria della salute porta vantaggi in tutti i settori. Chiaramente deve essere un’azione costante e continua. Mantenere in buona salute la popolazione è un lavoro quotidiano.
Quindi speriamo che, anche attraverso questa norma, il lavoro fatto dal Gruppo di Studio Nazionale dell’ISS possa avere un effetto moltiplicatore diverso da zero che mette in primo piano l’azione di prevenzione primaria a cui tutti dobbiamo tendere. Questo a maggior ragione in un paese che ha una popolazione sempre più anziana che vive più a lungo, ma troppo spesso non più in salute.
Ai fini dell’ottenimento di condizioni di qualità dell’aria che garantiscano la salute degli occupanti negli edifici per usi civili (residenziale e terziario, edifici per l’istruzione), la presente norma specifica le modalità per rendere ripetibile e riproducibile il processo di registrazione delle informazioni che portano a tale valutazione. Fornisce inoltre una Check list per la raccolta di informazioni e i principali riferimenti per la valutazione dell’aria negli ambienti interni.