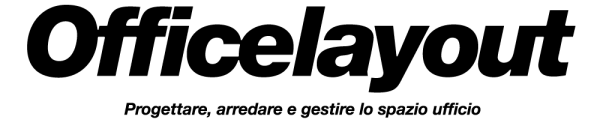La gestione dei dati nell’approccio BIM
Come analizzare il dato mediante computi, abachi e inventari, contribuendo ad aumentare l’efficienza del processo progettuale e realizzativo in termini di costi, tempi e valutazione dell’impatto ambientale
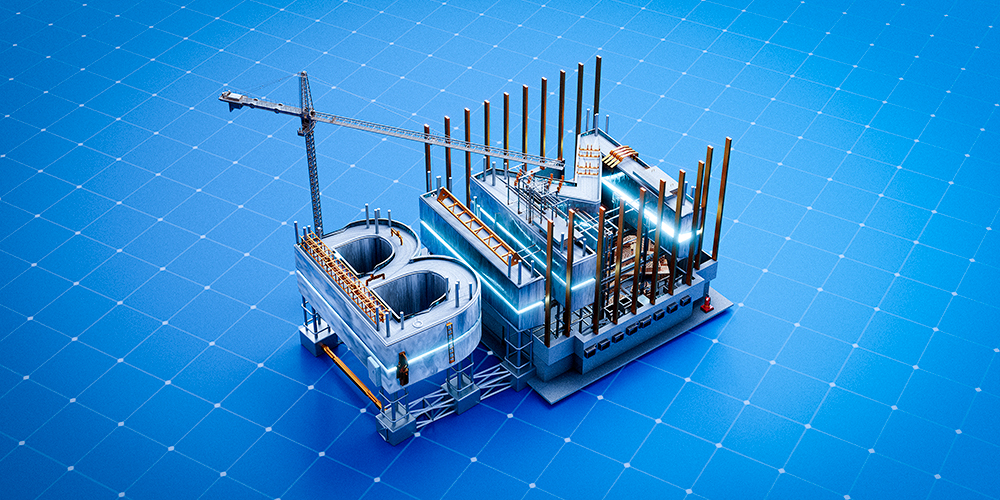
Articolo a cura di Chiara Tagliaro, ricercatrice presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano
Con questa rubrica, sviluppata nell’ambito delle attività condotte dall’Italian PropTech Network del Politecnico di Milano, si fa luce sul BIM come strumento utile ad affrontare le sfide odierne legate alla progettazione e gestione degli spazi di lavoro. Dopo aver presentato, nella prima puntata una panoramica generale sul BIM e le sue applicazioni, a cui è seguito un approfondimento sul tema dell’illuminotecnica e analisi energetica, in questo terzo appuntamento, con il contributo di RT BIM Lab, si approfondiscono le applicazioni di questo strumento per la gestione dei dati attraverso la creazione di un catalogo digitale.
Grazie alla sua capacità di integrare dati e informazioni in un unico modello parametrico, il Building Information Modeling (BIM) consente una migliore gestione del ciclo di vita degli edifici, dalla progettazione alla costruzione, fino alla manutenzione e allo smaltimento.
Questo articolo si propone di illustrare come, attraverso i cataloghi digitali di oggetti, il BIM consenta di analizzare il dato mediante computi, abachi e inventari, contribuendo ad aumentare l’efficienza per processo progettuale e realizzativo in termini di costi, tempi e valutazioni di impatto ambientale.
Il BIM può essere definito come un processo intelligente basato su modelli digitali 3D che, non solo aiutano a rappresentare graficamente un oggetto, ma contengono e forniscono informazioni dettagliate sui caratteri fisici e funzionali di un edificio. Non si tratta, quindi, solo di un software, ma di un “approccio integrato” alla gestione delle informazioni. Attraverso il BIM, i professionisti del settore possono collaborare in modo più efficace, proprio accedendo alla lettura del dato, che consente di condividere informazioni e lavorare insieme su un’unica piattaforma, migliorando così la trasparenza e la comunicazione tra tutti gli attori coinvolti nel progetto.
La gestione dei dati è un aspetto cruciale nell’approccio BIM, in quanto consente di coordinare e organizzare in modo efficiente le informazioni provenienti da diverse fonti. In un contesto tradizionale, i dati che riguardano la progettazione, costruzione e gestione di un edificio si trovano generalmente disaggregati e, per questo motivo, risultano difficili da gestire, soprattutto nel momento in cui devono essere trasferiti a professionalità diverse. Per ovviare a questo problema, il metodo BIM offre una soluzione centralizzata che facilita l’accesso e la manipolazione delle informazioni.
Le ‘dimensioni’ del BIM
In base alle tipologie di dati disponibili nel modello parametrico, si parla di “Dimensioni”. Le Dimensioni servono a schematizzare i diversi livelli di informazione di un modello BIM, ovvero le “potenzialità” che l’informatizzazione del progetto permette. La normativa di riferimento BIM in Italia, la UNI 11337 definisce e individua 7 Dimensioni, mentre ulteriori 3 sono in fase di dibattito.
Tra queste, la terza dimensione (3D) è quella che delinea la forma e la geometria dell’edificio. La quarta dimensione (4D) rappresenta il tempo, e grazie all’inserimento dei dati temporali nei singoli oggetti degli edifici è possibile pianificare e gestire le varie fasi di costruzione, nonché monitorarne i progressi in relazione al cronoprogramma. La quinta dimensione (5D) corrisponde al costo: questi dati consentono una stima dei costi associati a materiali, manodopera e tempistiche di realizzazione. Grazie alla quinta dimensione, è possibile estrapolare velocemente i computi estimativi e gestire il budget, aumentando quindi la capacità di prevedere e prevenire eventuali spese impreviste. La sesta dimensione (6D) si riferisce alle informazioni sull’efficienza energetica e sulla sostenibilità, permettendo di analizzare il ciclo di vita dell’edificio e le prestazioni ambientali. Infine, la settima dimensione (7D) comprende la gestione dei dati sulle strutture, facilitando la manutenzione e l’operatività dell’immobile nel corso del tempo.
Oltre alle già citate dimensioni esiste un dibattito aperto su tre “nuove dimensioni del BIM”. L’8D identifica ciò che concerne i dati sulla sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell’opera. La 9D include tutte quelle informazioni da assegnare al modello, che garantiscono una ottimizzazione delle fasi di realizzazione dell’opera, nonché di una gestione efficiente delle risorse e una minimizzazione degli sprechi. Mentre la 10D punta all’obiettivo di industrializzare il mondo delle costruzioni per incrementarne la produttività integrando dati commerciali, fisici o ambientali.
Strumenti di computo integrati nel software BIM
Uno dei vantaggi principali dell’utilizzo del metodo BIM, e quindi della parametrizzazione del progetto, sono proprio i cataloghi digitali, da cui conseguono una serie di operazioni. Tra queste, i computi, ovvero l’elenco dettagliato dei materiali e delle quantità necessari per completare un progetto, rappresentano il cuore della gestione dei dati nelle varie Dimensioni, attraverso il processo BIM. Utilizzando strumenti di computo integrati nel software BIM, è possibile generare automaticamente le quantità di materiali a partire dai modelli 3D. Questo non solo riduce il potenziale di errore umano, ma migliora anche la precisione delle stime di costo.
I benefici che i computi BIM apportano al progetto si possono riassumere in tre parole chiave:
• Automazione: i computi vengono aggiornati automaticamente ogni volta che vengono apportate modifiche al modello, o a ogni singola componente specifica del modello. Questo permette alle figure professionali che gravitano intorno al progetto di risparmiare tempo evitando la reiterazione di attività di e ridurre il rischio di errori.
• Precisione: le quantità generate tramite il modello BIM sono più accurate rispetto ai metodi tradizionali, poiché riflettono esattamente le specifiche del progetto. Ciò consente di ovviare a una serie di approssimazioni tipiche degli approcci manuali.
• Collaborazione: condividere i computi tra i diversi gruppi di lavoro diventa più semplice, consentendo una maggiore coesione e allineamento degli obiettivi. Questo rende la comunicazione tra le diverse professionalità che ruotano attorno al progetto molto più fluida e costante nel tempo.
Nonostante i vantaggi, la gestione dei dati nel BIM presenta alcune sfide.
Una delle principali è la qualità dei dati, in quanto informazioni imprecise o incomplete possono portare a decisioni errate. È quindi essenziale implementare pratiche rigorose di controllo della qualità per garantire l’affidabilità delle informazioni. Molto spesso, per la creazione di un modello BIM, ci si appoggia a degli “incubatori web”: delle vere e proprie librerie online che consentono di scaricare elementi 3D parametrici creati da singoli utenti o dalle aziende stesse. Queste, porteranno con sé tutte le caratteristiche reali dell’oggetto che stiamo utilizzando sotto forma di gemello digitale (digital twin). Spesso, uno dei problemi che riscontriamo sta proprio nell’affidabilità dei parametri inseriti da chi ha creato l’oggetto, che molte volte non vengono settati in modo corretto e creano quindi delle incongruenze all’interno del progetto e, conseguentemente, dei computi. Una delle raccomandazioni principali, quando si opera in ambiente BIM, è proprio quella di revisionare sempre gli oggetti 3D di interesse e controllare attentamente tutti i loro parametri, prima di inserirli e quindi utilizzarli all’interno del progetto. Il controllo e la gestione di questi dati richiedono specifiche competenze. Viene da sé che le figure professionali impiegate e operative nel campo del BIM debbano essere adeguatamente formate per utilizzare strumenti come la creazione di modelli 3D collegati correttamente ai loro parametri.
Infine, la compatibilità tra diversi software di progettazione rappresenta un’altra sfida. Il BIM, infatti, non lavora in un ambiente isolato, ma necessita di connessioni e trasferimenti di informazioni con altri strumenti professionali. È fondamentale che i vari strumenti utilizzati nel processo possano comunicare tra loro per facilitare la condivisione dei dati.
Guardando al futuro, possiamo aspettarci un’evoluzione continua nella gestione dei dati attraverso il BIM nel senso di una sempre maggiore integrazione delle tecnologie emergenti. Tra queste, l’intelligenza artificiale e il machine learning potranno migliorare ulteriormente la capacità di analisi dei dati e la previsione delle esigenze di progetto. Inoltre, l’adozione di standard aperti per il BIM potrebbe facilitare l’interoperabilità tra diversi sistemi, consentendo una maggiore flessibilità nella scelta degli strumenti e dei software da utilizzare.
Dalla teoria alla pratica
È quindi evidente che la gestione del dato attraverso i computi nel metodo BIM rappresenta un elemento chiave per ottimizzare le attività nel settore delle costruzioni. Grazie a un approccio sistematico e integrato, è possibile migliorare la precisione delle informazioni, ottimizzare i costi e facilitare la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Affrontare le sfide attuali e prepararsi per le innovazioni future sarà fondamentale per garantire che il BIM continui ad apportare valore al processo edilizio, contribuendo a costruzioni più efficienti, sostenibili e intelligenti. Per mostrare nel concreto queste applicazioni legate al BIM, chiediamo a Dario Ruberti e Gabriele Tagliareni di RT BIM Lab di accompagnarci nel percorso di progettazione affrontato per uno dei tre piani dell’headquarter di una società danese, situata ad Aarhus, che opera nel retail.
Quale è stato il ruolo specifico dei cataloghi digitali all’interno del processo BIM di questo progetto?
Gabriele Tagliareni: I cataloghi digitali sono stati strumenti cruciali per la creazione di questo progetto, perché forniscono una fonte centralizzata di dati sui prodotti e le soluzioni disponibili sul mercato. Questi cataloghi ci hanno permesso di ottenere informazioni dettagliate su dimensioni, caratteristiche tecniche e prestazioni dei materiali, rendendo più facile il processo decisionale dell’intero progetto. Integrando questi cataloghi nel software BIM, siamo riusciti a generare automaticamente stime dei costi e verifiche di conformità con le normative vigenti.
In che modo le librerie digitali di oggetti hanno migliorato l’efficienza progettuale e la sostenibilità del progetto?
Dario Ruberti: I cataloghi digitali hanno notevolmente contribuito all’efficienza progettuale poiché facilitano l’accesso a informazioni aggiornate e affidabili. Nel nostro caso, hanno nettamente ridotto il tempo necessario per la ricerca dei materiali e la creazione degli stessi oggetti che vanno a comporre il progetto. Inoltre, questi cataloghi possono includere dati riguardanti la sostenibilità, come ad esempio il consumo di alcuni elettrodomestici, i lumen degli apparecchi illuminanti o le caratteristiche termiche delle aperture. Ciò ci ha concesso, nel nostro ruolo di progettisti, di selezionare oggetti con caratteristiche che minimizzano l’impatto ambientale. Questo aspetto è stato molto rilevante, dato che molte normative e linee guida con le quali ci siamo interfacciati, richiedevano pratiche costruttive sostenibili.
Qual è l’aspetto più concreto dove avere dei “digital twin” è stato cruciale per il progetto?
Gabriele Tagliareni: L’aspetto più significativo è stato senz’altro durante la fase preliminare, quando è arrivato il momento di vagliare e valutare diverse opzioni di progetto. Qui, l’uso di cataloghi digitali ha permesso di selezionare materiali compatibili dal punto di vista estetico e funzionale. Grazie alla loro integrazione nel processo BIM, è stato possibile confrontare rapidamente le diverse alternative possibili, valutarne le conseguenze in termini di costi e tempi e, infine, scegliere quella più adatta rispettando le richieste del cliente ma, allo stesso tempo, avendo un responso immediato in merito al budget. La trasparenza dei dati ha inoltre facilitato la comunicazione con le autorità locali, accelerando le approvazioni necessarie al progetto.
Che cosa renderebbe ancora più efficiente l’utilizzo delle librerie digitali nei vostri progetti?
Dario Ruberti: Una delle principali sfide, che renderebbe più organizzata la filiera delle costruzioni, è sicuramente la standardizzazione dei dati. I cataloghi digitali di librerie sono spesso creati da diversi fornitori e possono variare nel formato e nella qualità delle informazioni. Ciò può portare a difficoltà nel loro utilizzo integrato all’interno di un modello BIM. Un altro aspetto, sempre legato alla correttezza del modello 3D e quindi del dato, è la necessità di formazione per i professionisti del settore, affinché possano utilizzare questi strumenti in modo efficace e diffuso. La resistenza al cambiamento da parte di alcune aziende tradizionali, che sono abituate a metodi di lavoro meno digitalizzati, è notevole e ciò riduce molto il potenziale di pervasività e applicabilità di questo strumento.
Qual è il futuro dei cataloghi digitali e del metodo BIM nel contesto dell’industria delle costruzioni?
Gabriele Tagliareni: Il futuro sembra promettente per le librerie digitali di oggetti e per il metodo BIM, più in generale. Con l’evoluzione della tecnologia, prevediamo una maggiore integrazione tra sistemi diversi, facilitando così un flusso di lavoro più fluido e una collaborazione migliore tra le parti coinvolte. Inoltre, l’adozione crescente di procedure di costruzione sostenibili e l’uso di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, arricchiranno ulteriormente l’esperienza dell’utente nel contesto BIM. I cataloghi digitali diventeranno sempre più sofisticati, includendo informazioni in tempo reale e assistendo nella manutenzione predittiva degli edifici.
In conclusione, come ha evidenziato RT BIM LAB, i cataloghi digitali rappresentano una risorsa fondamentale per massimizzare i benefici del metodo BIM nel settore delle costruzioni. Grazie alla loro capacità di centralizzare informazioni critiche, migliorare l’efficienza progettuale e promuovere la sostenibilità, stanno contribuendo a un cambiamento significativo nel modo di affrontare i progetti edilizi. È evidente che l’integrazione di questi strumenti digitali sarà sempre più cruciale per affrontare le sfide e le opportunità future del settore.