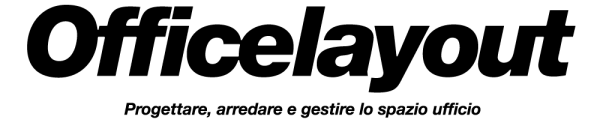Spazio al benessere
Come progettare ambienti che riducano i fattori di stress ambientale e socio-ambientale e che rispondano ai bisogni psicologici legati allo spazio nei luoghi di lavoro

Articolo a cura di Lucilla Malara*
L’ambiente fisico non è solo il contesto in cui si svolge l’attività lavorativa, ma una componente che incide direttamente sul benessere delle persone, influenzando comportamenti, performance e qualità delle relazioni. Oggi il tema del benessere psicofisico sul luogo di lavoro è al centro delle dinamiche aziendali e degli interessi delle persone, soprattutto delle nuove generazioni.
È importante considerare che uno spazio ben progettato può agevolare lo svolgimento delle attività quotidiane, sostenere la concentrazione, favorire la collaborazione e, al contempo, declinare il modello organizzativo, i valori e l’identità dell’organizzazione. In un’ottica di sostenibilità e continua trasformazione dei modelli organizzativi, la qualità degli ambienti di lavoro diventa sempre più una leva strategica per le aziende.
Quando gli ambienti non rispondono in modo adeguato alle esigenze e ai bisogni di individui e organizzazioni, possono trasformarsi in fonti di disagio. Se le condizioni ambientali disfunzionali persistono nel tempo, il disagio iniziale può evolvere in una vera e propria insoddisfazione lavorativa, fino a generare stress percepito.
Secondo il modello di Lazarus e Folkman (1984), lo stress è il risultato di un processo di valutazione cognitiva dell’interazione tra individuo e ambiente, cioè di interpretazione dello stimolo ambientale come potenzialmente minaccioso, e di valutazione delle risorse disponibili per affrontarlo, attivando eventuali strategie di coping. Se queste risorse risultano sufficienti, si genera eustress (una forma di stress positivo che rafforza la resilienza). In caso contrario, si manifesta distress, con ripercussioni fisiche, psicologiche e comportamentali che variano da persona a persona. È fondamentale sottolineare la dimensione soggettiva della risposta allo stress. Fattori come età, personalità, cultura, educazione, ma anche la resilienza individuale, influenzano profondamente la percezione degli stimoli ambientali e la capacità di adattarsi a essi. Possiamo quindi affermare che lo stress è la conseguenza di uno squilibrio tra le richieste ambientali e le risorse individuali, uno stato di tensione fra individuo e l’ambiente fisico e sociale.
I fattori di stress ambientale e socio-ambientale nei luoghi di lavoro
In questo contesto, la Psicologia Ambientale distingue due principali fattori di stress legati allo spazio: stress ambientale e stress socio-ambientale.
1) Lo stress ambientale è generato da caratteristiche fisiche del contesto, quali la presenza o l’assenza di alcuni elementi o caratteristiche dell’ambiente, la quantità e qualità delle informazioni e di stimolazione sensoriale che influiscono sulle risorse fisiologiche a cui si è esposti che, se non adeguatamente progettate, possono sovraccaricare le risorse percettive e fisiologiche dell’individuo, generando malessere, distrazione o affaticamento.
Tra i principali fattori troviamo:
• Inquinamento acustico: i suoni quando superano una determinata soglia vengono percepiti come “rumore” e quindi fastidiosi o intrusivi. Provenienti sia da fonti interne (colleghi, dispositivi, impianti, ecc.), sia da sorgenti esterne (traffico, cantieri, aeroporti, allarmi, ecc.), interferiscono con la concentrazione, la collaborazione, la comunicazione, l’attenzione verso gli altri, sottraggono l’attenzione cognitiva, contribuiscono alla fatica mentale, possono anche influenzare la valutazione estetica di un luogo e mascherare la percezione di segnali di allarme.
• Inadeguata qualità e ventilazione dell’aria: una qualità dell’aria povera di ossigeno o ricca di agenti chimici nocivi (monossido di carbonio, particolato da stampanti-fotocopiatrici, componenti organici volatili rilasciati da materiali, formaldeide, muffe, batteri, virus da impianti di condizionamento) incide negativamente sul benessere psicofisico, causando irritazioni, mal di testa e cali di performance. Anche il flusso dell’aria, se diretto, insufficiente o mal distribuito, può generare stress ambientale.
• Dis-comfort termico: Temperature percepite come troppo alte o troppo basse rispetto alla soglia individuale di comfort termico possono interferire con i processi fisiologici, percettivi e cognitivi. Se questa condizione si prolunga nel tempo, diventa una fonte significativa di stress.
• Inquinamento dell’acqua: si verifica quando le fonti idriche, come impianti idrosanitari o sistemi di raffrescamento, vengono contaminate da sostanze nocive di origine chimica, biologica o fisica. Queste contaminazioni possono compromettere la salute dei lavoratori e la sicurezza ambientale.
• Inquinamento elettromagnetico: sebbene l’impatto dell’esposizione prolungata a campi elettromagnetici e radiofrequenze generati da dispositivi elettronici o impianti tecnologici, sulla salute sia ancora oggetto di ricerca scientifica, sappiamo che incide su vari aspetti legati alla sfera cognitiva, come la difficoltà di concentrazione e memoria, l’irritabilità e la stanchezza cronica.
• Illuminazione inadeguata: una luce artificiale inadeguata, eccessiva o insufficiente, non dinamica e non dimmerabile e non in equilibrio con i nostri ritmi biologi circadiani, oppure una scarsa esposizione alla luce naturale, può influenzare la nostra salute, la produttività ed emotività.
• Inquinamento cromatico: anche il colore degli ambienti incide sullo stato fisico e psicologico. Toni troppo saturi, disturbanti o monotoni o mal combinati rispetto agli utilizzi delle attività, possono indurre un disagio percettivo ambientale e peggiorare le prestazioni cognitive.
• Qualità complessiva dell’edificio: quando più fattori stressogeni coesistono e persistono, può insorgere la cosiddetta Sick Building Syndrome (SBS), una condizione in cui chi lavora all’interno dell’edificio sperimenta sintomi fisici e psicologici (malessere, affaticamento, irritabilità). Le cause, spesso multifattoriali, includono ventilazione inadeguata, presenza di inquinanti, illuminazione e acustica inadeguate.
2) Lo stress socio-ambientale è causato dall’effetto delle interazioni sociali e delle dinamiche relazionali tra individui che condividono uno stesso spazio e che influiscono sul piano emotivo e comportamentale. Tra i principali fattori di stress socio-ambientale troviamo:
• Spazio personale e prossemica: riguarda la gestione della distanza interpersonale tra le persone. Introdotto dall’antropologo Edward T. Hall (1966), questo concetto studia come gli individui organizzano lo spazio nelle relazioni e il loro rapporto con l’ambiente circostante. Hall ha identificato quattro distanze interpersonali: intima, personale, sociale e pubblica, che variano in base alla relazione tra le persone e sono influenzate da fattori come età, genere, cultura, educazione e personalità. Il mancato rispetto di queste distanze può causare stress socio-ambientale e attivare risposte comportamentali difensive.
• Sovraffollamento e mancanza di privacy: la percezione di sovraffollamento si verifica quando lo spazio disponibile appare insufficiente, generando disagio fisico, mentale e sociale. Questo può provocare affaticamento cognitivo (distrazione), alterazioni emotive (irritabilità) e reazioni comportamentali (aggressività). Allo stesso modo, la mancanza di privacy acustica (legata ai rumori e alla possibilità di essere ascoltati), visiva (relativa all’esposizione propria e altrui), o prossemica (il bisogno di mantenere una distanza interpersonale adeguata) può compromettere le performance e la qualità delle relazioni. Avere controllo sul proprio spazio è essenziale per regolare i rapporti sociali, le dinamiche relazionali e mantenere il proprio equilibrio psico-emotivo.
Questi elementi influenzano profondamente il modo in cui l’ambiente viene percepito e vissuto, incidendo sul benessere psicologico. Ogni fattore stressante, di tipo ambientale o socio-ambientale, può innescare una risposta complessa da parte dell’organismo:
• Fisica e fisiologica: affaticamento, disfunzioni cardiovascolari, muscolari e neuroendocrine
• Cognitiva: difficoltà di attenzione, memoria e concentrazione
• Emotiva: ansia, frustrazione, irritabilità
• Comportamentale: isolamento, calo della collaborazione, comportamenti disfunzionali.
Se prolungate, queste condizioni possono portare a esaurimento psicofisico e, in casi estremi, a conseguenze durature per la salute mentale e fisica. Per questo, è essenziale progettare ambienti che riducano al minimo le fonti di stress ambientale e socio-ambientale per garantire il benessere psicofisico delle persone.
Il comfort ambientale
Per comprendere le fonti di stress ambientale e socio-ambientale nei contesti di lavoro, è essenziale partire da una visione più ampia dell’ambiente costruito, centrata sul concetto di comfort ambientale. Se lo stress ambientale e socio-ambientale è generato da carenze o eccessi nelle condizioni fisiche, cognitive e sociali dello spazio, il comfort ambientale rappresenta il suo opposto, ovvero una condizione in cui le esigenze fisiche, cognitive e comportamentali dell’individuo trovano risposta.
Secondo Vischer (2008), il comfort ambientale si struttura su tre categorie gerarchicamente interconnesse. Il comfort fisico si riferisce alla sicurezza, all’igiene, alla qualità dell’aria, dell’acustica, della luce e alla temperatura, elementi che, se inadeguati, diventano stressogeni. Il comfort funzionale riguarda invece la relazione tra le persone e lo spazio operativo: la distribuzione degli ambienti, l’arredo, l’ergonomia e l’usabilità, tutti fattori che influenzano direttamente l’efficienza e la soddisfazione lavorativa. Infine, il comfort psicologico si lega agli aspetti più sottili e profondi dell’esperienza spaziale: il senso di appartenenza, la privacy, la gestione del proprio territorio e le relazioni sociali all’interno dell’ambiente. Secondo questo modello, una carenza in una categoria può̀ essere compensata da un punto di forza in un’altra, ma il comfort ambientale ottimale per le prestazioni lavorative si ottiene quando la qualità̀ dello spazio di lavoro è adeguata in tutte e tre le dimensioni.
I bisogni psicologici legati allo spazio
Ridurre lo stress non significa solo eliminare le fonti di disturbo, ma costruire ambienti che soddisfino bisogni psicologici spaziali legati allo spazio. Il primo tra questi è la sicurezza psicofisica, intesa come percezione di protezione e orientamento insieme a incolumità̀ e salute fisica, mentale ed emotiva. A seguire, la percezione di controllo sull’ambiente, che include la possibilità di regolare le condizioni ambientali circostanti, ma anche di gestire lo spazio personale, orientarsi e muoversi in autonomia. Questo è strettamente connesso al bisogno di privacy, un processo dinamico di regolazione tra isolamento e interazione sociale (Altman, 1975). Negli ambienti di lavoro, la configurazione degli spazi e degli arredi deve permettere di modulare le distanze interpersonali, in base alle attività svolte, sia individuali che collaborative. Con l’evoluzione dei modelli organizzativi, è sempre più importante progettare spazi che favoriscano un equilibrio tra privacy e socialità, adattandosi alle esigenze delle persone e delle organizzazioni. L’attaccamento al luogo rappresenta il legame emotivo e psicologico che le persone sviluppano nei confronti di spazi significativi, come il luogo di lavoro. Il bisogno di sentirsi connessi a un luogo è influenzato da esperienze personali, fattori soggettivi e significati culturali e sociali. In questa prospettiva, Edward Relph (1976) introduce il concetto di “sense of place”, ovvero il significato e il senso di appartenenza che attribuiamo a un determinato spazio. Non sono solo le caratteristiche fisiche a creare questa connessione, ma anche le relazioni sociali che vi si sviluppano, in grado di rafforzare il senso di comunità e ridurre la percezione di isolamento. Particolarmente rilevante in ambito lavorativo è la place identity, che mette in relazione i valori aziendali l’identità dell’individuo. Più un luogo rispecchia ciò in cui una persona si riconosce più forte sarà il senso di appartenenza. Quando i dipendenti percepiscono lo spazio di lavoro come parte di sé, aumenta l’identificazione con l’azienda e l’impegno verso l’organizzazione. La personalizzazione del proprio spazio di lavoro consente alle persone di esprimere sé stesse in base alle preferenze individuali, aumentando il senso di appartenenza, il comfort ambientale e la produttività.
Soluzioni progettuali per ambienti di lavoro rigenerativi, sicuri e identitari
I principi della Psicologia Ambientale e Architettonica insieme agli strumenti del Biophilic Design assumono un ruolo centrale nel processo progettuale, perché consentono di creare ambienti che non solo rispondono ai bisogni fisici, ma anche a quelli emotivi, cognitivi e comportamentali delle persone.
Alcune soluzioni progettuali sono in grado di promuovere un’esperienza spaziale positiva, rispondendo ai bisogni psicologici, sostenendo la cultura organizzativa e favorendo un ambiente di lavoro rigenerativo. È il caso degli spazi rigenerativi, che, secondo la Psicologia Ambientale, sono luoghi capaci di riequilibrare lo stato psicofisiologico e permettere alle risorse cognitive ed emotive delle persone di rinnovarsi. Le teorie come la Stress Reduction Theory di Ulrich (1984,1991) e l’Attention Restoration Theory dei coniugi Kaplan (1989) dimostrano che la presenza di elementi naturali ha effetti benefici misurabili sul benessere psicofisico. L’integrazione di stimoli naturali, anche artificiali, ma ispirati alla natura e ai sistemi naturali, può favorire micro-esperienze rigenerative, capaci di ridurre lo stress e recuperare l’attenzione cognitiva. Questo processo avviene attraverso un’attivazione automatica del sistema parasimpatico, che si innesca spontaneamente a contatto con elementi naturali, in minor misura quando sono simulati tramite materiali, forme, colori o suoni. Si tratta quindi di uno strumento efficace e scientificamente fondato per il recupero psicofisico e la rigenerazione dell’attenzione volontaria.
La progettazione deve garantire sicurezza negli spazi di lavoro ovvero creare ambienti leggibili, privi di ostacoli con una buona luce, segnaletica e organizzazione spaziale, facilmente navigabili anche in caso di emergenza con percorsi chiari, punti di riferimento visivi (landmark) e nodi funzionali che favoriscono la creazione di una mappa cognitiva migliorando il senso di autonomia e di controllo delle persone sull’ambiente. Allo stesso modo, garantire la privacy visiva, acustica e prossemica è essenziale per ridurre lo stress: arredi e layout ben studiati, divisori riconfigurabili, materiali fonoassorbenti, permettono di migliorare il comfort, favorire la concentrazione e supportare il benessere psicofisico delle persone. L’invasione dello spazio personale o l’esposizione a stimoli eccessivi rappresentano infatti fattori di disagio che la progettazione può e deve mitigare. Un altro aspetto cruciale è la possibilità di personalizzare il proprio spazio di lavoro. Il benessere psicologico e il senso di appartenenza aumentano quando le persone possono adattare l’ambiente alle proprie preferenze. Questo vale anche nei contesti lavorativi flessibili e ibridi, dove la possibilità di inserire elementi personali è spesso limitata. Allo stesso modo, progettare spazi che riflettano la cultura e i valori aziendali attraverso scelte cromatiche, arredi, elementi visivi e richiami alla storia o al territorio aiuta a costruire una forte place identity e un senso di attaccamento al luogo. La percezione di controllo sul proprio ambiente è un bisogno fondamentale. Quando le persone possono regolare le caratteristiche ambientali dello spazio o selezionare luoghi adatti alle specifiche attività, sviluppano maggiore autonomia, motivazione ed efficacia personale. L’adozione di layout flessibili, tecnologie per il controllo ambientale e soluzioni modulari consente di soddisfare questo bisogno.
Integrare queste scelte con i principi della Psicologia Ambientale e Architettonica utilizzando gli strumenti del Biophilic Design può rappresentare una strategia efficace per garantire e bilanciare benessere individuale e organizzativo. In sintesi, solo attraverso un approccio integrato che unisca la riduzione dei fattori di stress alla progettazione di ambienti sani e rispondenti ai bisogni psicologici legati allo spazio, capaci di promuovere performance sostenibile, è possibile realizzare contesti di lavoro centrati sul benessere delle persone e sull’efficacia organizzativa.
* Lucilla Malara
Architetto, biophilic designer, consulente in Psicologia Architettonica e co-autrice, insieme a Donatella Mongera, del libro “Spazio al benessere. Come la Psicologia Ambientale e il Biophilic Design possono rigenerare l’ambiente di lavoro”, edito da Guerini Next.
Dirige lo studio di architettura Malara Associati, dove coordina un team interdisciplinare in tutte le fasi del processo progettuale, sviluppando soluzioni su misura per ogni intervento.
La filosofia progettuale dello studio mette al centro la persona e l’ascolto attento dei bisogni aziendali e individuali (Human & Organization Centred Design). Con approccio tailor made che applica i principi e gli strumenti della Psicologia Ambientale e Architettonica, del Biophilic & Restorative Design.